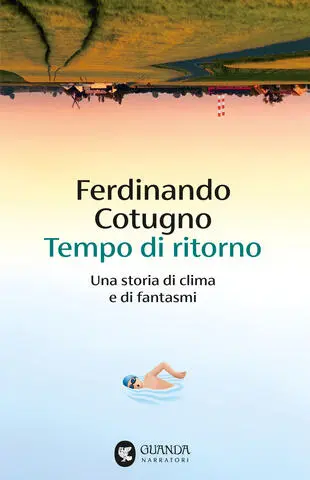Tempo di ritorno una storia di clima e di fantasmi.
Storia familiare e sfruttamento della terra nel romanzo di Ferdinando Cotugno
Sinossi
In statistica, il tempo di ritorno è la probabilità che un evento estremo si verifichi.
È il tempo che ci mettono a ripresentarsi i grandi traumi, gli amori, gli scudetti, gli attacchi di panico, i messaggi che disperatamente aspettiamo, le ondate di calore, le alluvioni.
La crisi climatica, con le sue catastrofi a distanza sempre più ravvicinata, ci ha trasformato in una società post traumatica di massa. In questo libro, il tempo di ritorno però è anche il viaggio a ritroso del protagonista nella storia della sua famiglia, che una volta è stata «una piccola nazione fondata sui combustibili fossili»: il nonno operaio all’Italsider, il padre camionista, la madre che passa dagli studi umanistici alla gestione di una ditta di trasporti.
Una storia di carbone e gasolio che nasce e riannoda i suoi fili nella zona industriale di Napoli, e si fa parabola per raccontare l’Italia intera dal dopoguerra a oggi. Non è una storia di clima ma, come ogni storia, è anche una storia di clima. Due generazioni che si ritrovano: quella dei padri che hanno lottato per uscire dalla povertà e costruire un piccolo benessere, e quella dei figli che quel benessere lo hanno ereditato, assieme a un mondo sul punto di collassare.
Solo se impariamo ad abitare questa contraddizione e riconosciamo di essere compromessi in prima persona con il processo che sta conducendo la Terra all’inabitabilità, possiamo provare a sovvertire quello che sembra un destino già tracciato. Perché «l’ecologia è l’amore di chi non ha alternative» e noi, specie umana, non abbiamo un altro posto dove andare.
Recensione
“Se c’è un’Anima del Mondo e noi ne facciamo parte, allora ciò che accade nell’anima esterna accade anche a noi. L’estinzione degli animali, come quella delle piante, è una sofferenza insita nel mondo. Noi siamo parte dell’anima mundi e intimamente soffriamo della sofferenza che vi si sta producendo.”
Si deve a James Hillman, alla fine del secolo scorso, l’intuizione della profonda correlazione tra distruzione ecologica e depressione psichica. A distanza di un secolo dalla riflessione del celebre psicoanalista, pochi di noi oserebbero contestare quella che appare come una verità inossidabile.
Ferdinando Cotugno ne Tempo di ritorno segue il duplice binario della crisi climatica e della storia familiare per raccontare gli innumerevoli fili che ci legano ai destini della terra. Lo fa usando la forma ibrida del romanzo intrecciato a inserti saggistici e impiegando la sua famiglia come rappresentante di un sistema capitalistico di sfruttamento del mondo.
Laddove Hillmann parlava di “anima mundi”, Cotugno, in forma più prosaica e scientifica, cita studi, ricerche, che disvelano quello che è sotto gli occhi di tutti.
Riporto dal suo libro, a titolo di esempio: “Un decennio dopo l’uragano Sandy che ha colpito New York nell’ottobre 2012, uno studio di neuroepidemiologia climatica ha misurato l’incremento del rischio di disturbi mentali per i figli delle donne che erano in stato di gravidanza quando la tempesta del secolo si era abbattuta sulla città. Per le bambine esposte all’uragano durante la fase prenatale, il rischio di sviluppare un disturbo ansioso era aumentato di venti volte, quello di avere una depressione di trenta. Per i maschi essere stati esposti a Sandy nel grembo materno aveva aumentato di sessanta volte la probabilità di soffrire di deficit dell’attenzione.
La tempesta ti cambiava il futuro prima ancora che avessi un presente. Il clima non modifica solo il paesaggio naturale, scrive Clayton Page Aldern nel libro The Weight of Nature, influisce anche su quello neurologico. L’accumulo di CO2 in atmosfera e il caldo che ne consegue peggiorano la capacità di prendere decisioni, di imparare, di risolvere problemi complessi. Secondo uno studio di economisti cinesi, gli studenti che affrontano gli esami di matematica in giornate che superano i 32 gradi perdono l’equivalente di un semestre di apprendimento.
È la stessa soglia di temperatura che fa aumentare la violenza nei confronti del servizio postale americano del cinque per cento. In Finlandia quasi metà delle oscillazioni statistiche dei crimini violenti può essere correlata all’aumento delle temperature esterne”.
Lo sfruttamento delle risorse ambientali ci sta rendendo dunque più aggressivi, più infelici e meno intelligenti.
Cui prodest, dunque? Se siamo consapevoli degli esiti nefasti del nostro modello di sviluppo, cosa ci impedisce di trovare e mettere in pratica delle alternative? Cosa ci sta bloccando?
Cotugno si mette in ascolto dei suoi genitori, prova a comprendere se dietro certi ostacoli non ci siano in realtà abitudini, storie, memorie difficili da scalfire. Il padre Luigi, figlio di un operaio dell’Italsider, poi autista di camion e piccolo imprenditore di una ditta di trasporti, pur accorgendosi delle estati sempre più calde, si mostra, nel racconto del figlio, privo di sensi di colpa e piuttosto disorientato di fronte a un mondo completamente diverso da quello che ha conosciuto da piccolo.
Non fa la raccolta differenziata perché non crede nell’economia circolare, ha immesso, con i suoi camion, tonnellate di gas di scarico nell’atmosfera e adesso ammette candidamente: “Non ci si capisce più niente”. Similmente stanca e nostalgica appare la madre Giuseppina, dapprima domestica in una famiglia della borghesia di Napoli e poi aiutante del marito nella conduzione dell’impresa di trasporti.
Torna il tema dell’infelicità
“Se almeno distruggere questo pianeta ci avesse reso felici. Se almeno fosse servito a qualcosa. Erano giovani esseri umani carichi di magia, percepita con gli strumenti e le personalità che avevano. Le radici dell’infelicità collettiva (della quale la mia famiglia è un affidabile carotaggio) e quelle del riscaldamento globale (al quale la mia famiglia ha portato un infinitesimale contributo) sono le stesse, è lo stesso albero, lo stesso progetto di vita umana sulla Terra. Siamo stati carnefici climatici, e non siamo stati nemmeno carnefici felici. Finché saremo in un rapporto di distruzione reciproca con il pianeta che abitiamo, l’infelicità sarà l’unico esito possibile.”
Cotugno non parla di colpe ne Tempo di ritorno, ma di responsabilità, annidate nelle storie personali di ciascuno di noi. Ci consegna così un esercizio di ascolto delle storie, proprie e altrui, che ci può tornare utile tutte le volte in cui non troveremo risposte convincenti di fronte a certi comportamenti (auto)distruttivi.
Autore

Ferdinando Cotugno è un giornalista e saggista italiano. Si occupa di ecologia, clima e politica. Ha collaborato con quotidiano “Domani” curando la newsletter Areale.
Nel 2020 ha pubblicato Italian Wood. Alla scoperta di una risorsa che non conosciamo, i nostri boschi (Mondadori), nel 2022 Primavera ambientale. L’ultima rivoluzione per salvare la vita umana sulla Terra (Il Margine).
Tempo di ritorno è il suo esordio nella narrativa