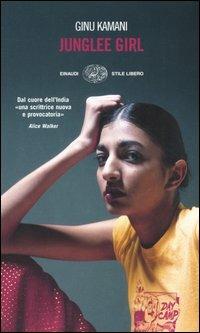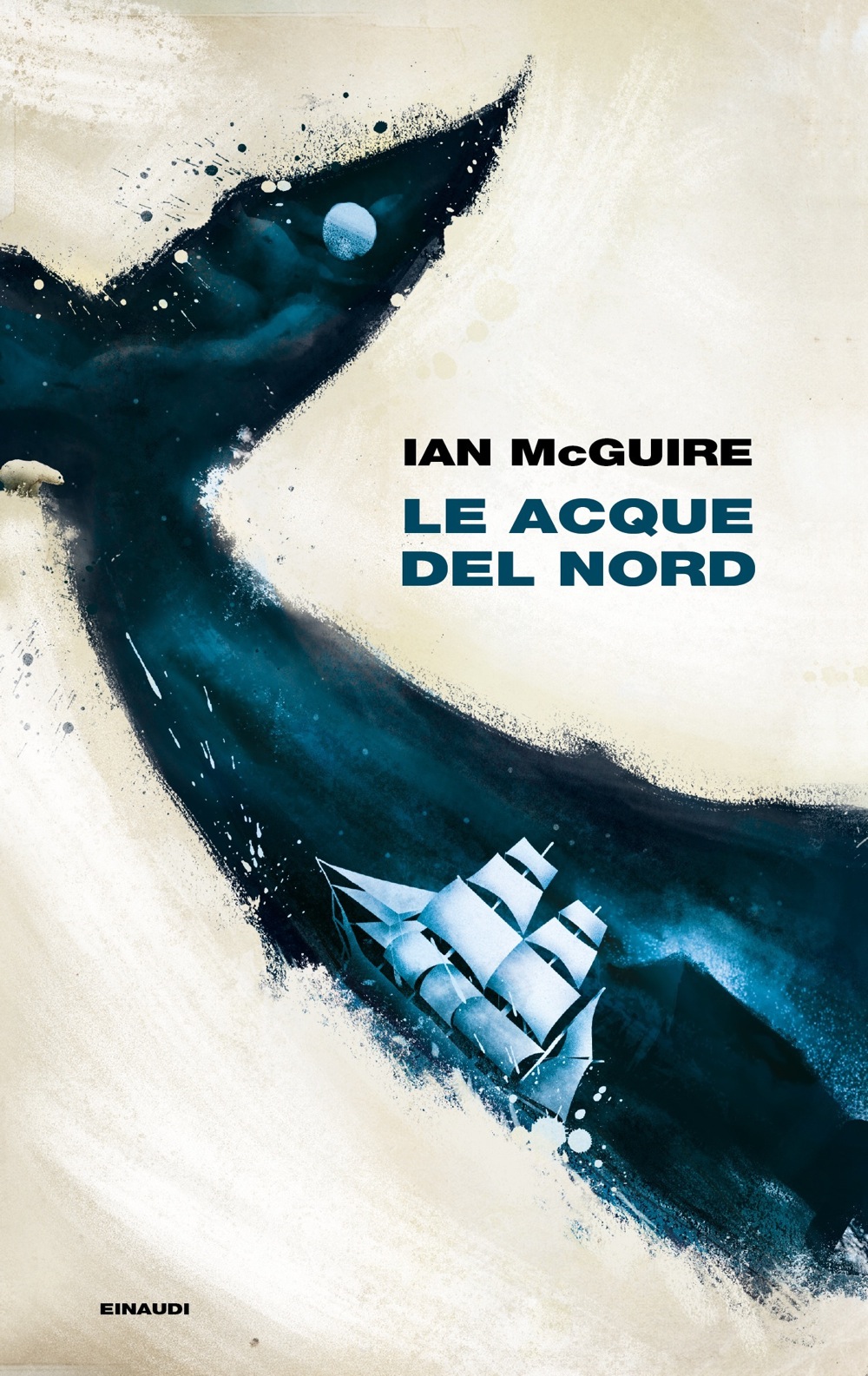Oggi abbiamo il piacere di incontrare un grande professionista ed un caro amico: Andrea Sirotti.

Andrea Sirotti, anglista e postcolonialista, ha tradotto e curato per diversi editori antologie e raccolte poetiche di autrici come Emily Dickinson, Margaret Atwood, Carol Ann Duffy, Eavan Boland, Alexis Wright e Arundhathi Subramaniam.
Insieme a Shaul Bassi ha curato Gli studi postcoloniali. Un’introduzione (Le Lettere, Firenze 2010). Per Einaudi ha tradotto testi narrativi di Lloyd Jones, Ginu Kamani, Hisham Matar, Hari Kunzru, Aatish Taseer, Chimamanda Ngozi Adichie e Ian McGuire.
1. Buongiorno Andrea, la prima domanda immagino sia scontata e riguarda il tuo percorso professionale: come sei arrivato alla traduzione e soprattutto come sei arrivato a tradurre dall’inglese delle colonie?
«Allora inizierei dicendo che quando ho cominciato io erano altri tempi. Lo anticipo perché quando mi trovo a parlare con aspiranti traduttori, ad esempio, mi rendo conto che la situazione è molto cambiata.
È molto cambiata perché ai miei tempi, era la fine degli anni 90, c’era una fioritura particolare di letteratura che al tempo si usava chiamare post-coloniale, che a dire il vero è un po’ un termine ombrello, un termine di comodo, però diciamo per essere chiari che andava abbastanza di moda la letteratura indiana, così come quella africana o caraibica di lingua inglese. Basta pensare ai premi Nobel in quegli anni, tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000.

Io non è che avessi una particolare formazione o predisposizione per questo tipo di letterature, ma nemmeno per la traduzione, non ero stato formato come traduttore. Semplicemente facevo parte della redazione di Semicerchio, una rivista fiorentina di poesia comparata, e avevo cominciato semplicemente a fare delle piccole traduzioni di singole poesie o di brevi brani per i numeri tematici della rivista, così come qualche recensione di uscite poetiche.
Diciamo che mi attraeva molto, al tempo, questa idea degli altri inglesi, della letteratura in lingua inglese però non WASP, non americana o britannica. Mi attirava perché semplicemente da lettore mi piaceva molto, sentivo che c’era una certa novità, una freschezza che magari certe poesie, diciamo più accademiche o più standard, avevano un po’ perso sentendo di più il peso della tradizione, mentre nelle poesie postcoloniali o nella letteratura postcoloniale indiana in lingua inglese, in particolare, si sentiva questa maggiore libertà, questa maggiore freschezza.
In qualche modo giocavano con la tradizione, venivano a patti con una tradizione che comunque era piuttosto opprimente, pesante. Così, semplicemente da lettore, perché poi un traduttore non è altro che un lettore appassionato, un lettore molto attento.
Ho cominciato a interessarmi a questo tipo di letteratura documentandomi per una recensione che dovevo fare di un’antologia che si chiamava Sixty Women Poets, edito da Bloodaxe.
Erano tutte donne, tutte poetesse, e immancabilmente le voci che sentivo più vicine a me, che mi incuriosivano, che mi attraevano di più, erano voci appunto indiane provenienti dalle ex colonie.
Così ho cominciato a interessarmi a queste autrici e ho proposto una antologia alla casa editrice Le Lettere, che era la stessa che al tempo pubblicava la rivista Semicerchio.
Fatta questa proposta un po’ coraggiosa, o intrepida diciamo, la editor del tempo la dottoressa Pescarolo, mi incoraggiò a confezionare una proposta editoriale, cosa che feci e che fu accettata. Si può dire che in qualche modo sia così che è cominciata la mia carriera di traduttore, da questa antologia che poi è stata pubblicata nel 1999 e che ha avuto una seconda edizione nel 2004 e quindi anche una certa attenzione dalla critica.
In occasione di un convegno, poi, portai una copia di un libro che avevo letto e mi era molto piaciuto ad Anna Nadotti, che aveva fatto una recensione della antologia sull’indice dei libri del mese e che allora collaborava come consulente per Einaudi.
Questa proposta editoriale fu passata a un’altra redazione, quella di Stile Libero, sempre in Einaudi, e Angela Tranfo la accettò.
Il libro che mi era piaciuto e per il quale mi ero in qualche modo battuto in realtà era di un’autrice che non era rientrata nella antologia delle poesie ma che mi era piaciuta come narratrice, si chiama Ginu Kamani, il libro era “Junglee Girl” ed è stato accolto molto bene. Poi Ginu è diventata una amica, è venuta più volte in Italia.
Diciamo che questo avvicinamento al mondo della poesia indiana in lingua inglese ha prodotto un po’ a cascata quelle che poi negli anni successivi sono state vere proprie commissioni da parte di Einaudi: essendomi spacciato per esperto di letteratura postcoloniale, la maggior parte degli autori che mi sono stati dati da allora sono di quelle aree lì, posso nominare Hisham Matar che è un un libico egiziano di lingua inglese, Hari Kunzru di padre Kashmiri e di madre inglese britannica, poi posso nominare Lloyd Jones che è un autore australiano, Alexis Wright che è una aborigena australiana, fino ad arrivare più recentemente ad autori africani come Chimamanda Adichie e altri autori sia di poesia, sia di narrativa ma anche di saggistica.
Erano altri tempi, ho esordito dicendo che effettivamente era un altro mondo editoriale in cui c’era forse più richiesta, era più semplice anche presentare semplicemente delle proposte sulla base di qualche interesse personale o di un curriculum.
Io semplicemente per anni avevo fatto l’insegnante, l’anglista di formazione, però oggi come oggi sicuramente la concorrenza è molto più ampia.
Oggi la crisi maggiore è dovuta alla intelligenza artificiale che ci sta pian piano soppiantando, anche nella letteratura che fino adesso è sembrata una zona franca in cui le macchine non osavano o non sapevano ancora entrare a sostituire la creatività umana, però in realtà va riconosciuto che molti passi sono stati fatti e temo che in futuro il mestiere del traduttore, mi rendo conto che questa è un’altra domanda, però il mestiere del traduttore si limiterà forse a un post-editing e quindi questo comporterà una riduzione del personale e quindi la prospettiva non mi sembra rosea. Però, magari, nella poesia, nella letteratura alta, in cui le questioni di stile sono preponderanti, forse ancora il fattore umano avrà da dire la sua. Forse.»
2. Tu hai tradotto anche Le acque del nord…
«Quello è un’eccezione, appunto in genere mi sono occupato di donne e di autrici di provenienza altra, le inglesi altre. Ian McGuire è stata una eccezione, in realtà non so bene perché mi è arrivata questa commissione da parte di Einaudi, forse per questo forte impianto storico e anche intertestuale, cosa che in effetti è centrale nella letteratura postcoloniale.
Comunque, fatto sta che l’editor di allora mi disse “Ah, Sirotti, ho pensato a te per questa specie di rilettura del Moby Dick, però in chiave molto dark, se non horror, in certi momenti addirittura noir”, e ovviamente ho accettato subito.
Dopo Le acque del nord ho tradotto anche un romanzo storico, un giallo storico come L’Astemio, sempre di Ian McGuire, con questa profonda ricerca sulla lingua parlata dagli irlandesi che vivevano nella Liverpool del movimento feniano, quindi con un legame con i moti feniani nella fine dell’800.

È una storia abbastanza classica, con un investigatore e un cattivo, quindi si trattava come traduttore di ricostruire, in una maniera che fosse plausibile oggi, un linguaggio che poteva essere pertinente a Dickens o Thackeray, agli autori dell’800.
È una scommessa perché chiaramente anche ritradurre un classico o un finto classico come questo pone tutta una serie di interrogativi. Quale linguaggio usare oggi per riprodurre un inglese che non è quello degli anni 50, non è quello degli anni 30, e chiaramente ogni decennio o ogni momento culturale ha un modo diverso di approcciarsi a un linguaggio ad esempio ottocentesco o settecentesco.
Ritradurre oggi il Daniel Defoe di Robinson Crusoe porta un risultato diverso rispetto a quanto fatto negli anni 50. Le traduzioni invecchiano, gli originali no. Per questo ci sono tanti modi per ritradurre un classico.
Ad esempio mi ha fatto molto piacere trovarmi a riscrivere Dickens attraverso il Mister Pip di Lloyd Jones, o come con Ian McGuire affrontare certi libri considerati di avventura, di mare, voyages più che journeys, ecco.
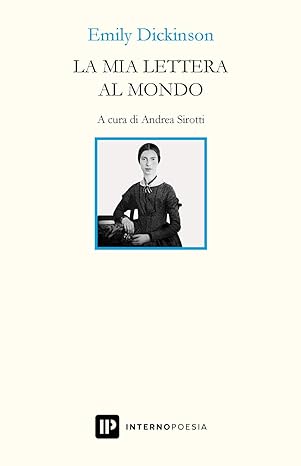
Mi ha fatto piacere perché è un modo di avvicinarsi alla traduzione dei classici che devo dire nella narrativa non ho mai sperimentato.
Cosa che invece mi è capitata nella poesia, perché ho ritradotto Emily Dickinson, ho editato e quindi co-tradotto le poesie di Oscar Wilde, di Tagore, però mi manca la ritraduzione dei classici della narrativa quindi non so, editori all’ascolto se volete mettermi alla prova lo faccio ben volentieri (ride).»
3. Dalle tue parole è evidente che il tuo è un approccio molto strutturato, accademico alla traduzione, con una parte di ricerca importante. Qual è a tuo avviso la differenza più rilevante tra il tradurre poesia e tradurre invece narrativa?
«È una differenza enorme, perché chiaramente la poesia ha tutta una serie di vincoli che la narrativa non ha o ha molto meno. Per tradurre poesia bisogna tener conto di tutta una serie di aspetti, di dominanti, che sono legate al contenuto ma anche alla sonorità, all’impianto fonico, al metro, alla misura dei versi, addirittura alle pause, al silenzio da cui la poesia emerge.
Bisogna tener conto di questi spazi di silenzio in in cui la sintesi poetica risuona. Questi problemi connessi al fatto di tradurre il silenzio, sembra una cosa assurda ma è proprio così, li ho avuti nel ritradurre Emily Dickinson, perché nella Dickinson anche all’interno del verso ci sono questi trattini che indicano un momento di pausa, di respiro, di pensiero che va enfatizzato, quindi le parole che circondano questi silenzi non devono essere eccessivamente ingombranti e ahimé l’italiano tende a essere una lingua plurisillabica piuttosto ingombrante.
Per tradurre poesia bisogna tener conto di tutte queste caratteristiche e di tutti questi vincoli.
Secondo alcuni è un mestiere destinato al fallimento, per cui un traduttore di poesia non può che sbagliare, il problema è cercare di sbagliare il meno possibile.
Un po’ come con i figli.
C’è un vantaggio però, ed è che la poesia non è commerciale, quindi il tuo errore non produce delle conseguenze di tipo economico, viceversa una brutta traduzione di narrativa può pesare sulle vendite. Chiaramente tu devi fare l’interesse del tuo autore, devi sapere essere non tanto fedele ma leale nei confronti del tuo autore, seguirlo, adattarti al tuo stile.
Devi chiederti, se lui o lei parlasse italiano, come direbbe queste cose, quale sarebbe il suo stile, quale sarebbe l’intonazione, il fluire giusto del suo periodare?
Il problema centrale è la ricerca della voce del narratore, anche se è un narratore onnisciente in terza persona, chiaramente sarà più orientato su un personaggio piuttoscto che su un altro, oppure potrebbe essere un narratore con una propria personalità ed essendo onniscente anche un suo giudizio.
Quindi è questione di trovare la voce giusta, non mettere troppe sovrapposizioni o fare troppe assunzioni, cioè “io credo che lui intenda dire questo”, bisogna rispettare esattamente ciò che l’autore dice, non mettere delle sovrastrutture magari sul tuo modo di interpretare le cose. Quando si traduce non bisogna farsi dei film, bisogna stare fissi, basati, fermi su quello che viene scritto, anche se non lo si condivide.
Capita spesso, pensare “ma cosa dice?” oppure “non mi sembra una cosa giusta, carina da dire” e invece è proprio quello che l’autore dice e quindi va rispettato.
E’ una questione ideologica ma soprattutto una questione di stile, se lo stile è molto frammentato, se c’è molta paratassi o viceversa una complessa ipotassi, tutto questo va rispettato. Non bisogna banalizzare troppo, se banale non è.
Se ci sono cose che magari il lettore italiano non capisce non bisogna correre il rischio di spiegarle troppo, neanche magari lasciarle troppo criptiche, perché l’inglese è molto più tollerante rispetto ai cosiddetti “realia”, quindi in un testo originale troveremo molte parole straniere. In italiano, tradizionalmente, le parole straniere si cerca di evitarle, spiegarle in qualche modo, lasciarle poi magari con una leggera spiegazione dopo, cosa che la traduzione anglosassone non vuole o non ammette.
Sono tutte questioni che vanno di volta in volta risolte, magari insieme a un buon editor che nel caso della traduzione si chiama revisore e che dovrebbe conoscere anche la lingua di partenza.»
4. Ecco, su questo pensavo una cosa: tu dici che quando si traduce, inevitabilmente si sbaglia, e c’è chi sostiene che non si debba tradurre però mi chiedo, anche per il lettore che parla decentemente inglese, anche se magari un inglese non letterario, il rischio di perdersi dei riferimenti storici, culturali è altissimo. Quindi che alternativa c’è al fidarsi del traduttore, in realtà?
«Allora, anche qui si deve un po’ distinguere tra narrativa e poesia.
L’alternativa sarebbero le note, anche se le note in poesia andrebbero evitate. Però io non sono contrario ad esempio a note esplicative, in fondo al libro. Questo per non distruggere, per non rovinare il fluire della poesia che poi, se tu stai attento a tutte queste dominanti di cui parlavo prima, il testo italiano dovrebbe simulare, dovrebbe avvicinarsi comunque a un testo che abbia una propria valenza poetica, che suoni come poesia, altrimenti è una traduzione in prosa e interlineare.
In questi casi un traduttore potrebbe decidere che le difficoltà e le complicazioni sono talmente tante che non osa affrontare una traduzione che possa dirsi poetica e quindi alla fine mettere giù una nota, un’unica enorme nota in cui dire “guarda la poesia dice queste cose qua”. Però non sarebbe traduzione.
Quindi direi che il traduttore è una persona estremamente spavalda, ma al tempo stesso anche umile perché lo fa per conto terzi, come a dire “Ok, ci provo, provo perlomeno a riprodurre quelle che io ritengo essere le caratteristiche irrinunciabili di questo testo che ne danno la poeticità”.
Un atto di grande coraggio ma anche di generosità perché ci si assume un rischio.

Comunque, se è vero che molto si perde, a volte qualcosa si recupera perché l’italiano magari ti consente miracolosamente di trovare un punto diverso, una certa immagine o assonanza, un gioco di parole che magari è andato perso in un altro punto del testo. In questo modo magari la traduzione non sarà fedele letteralmente, ma è leale.
Però una end note, soprattutto che chiarisca alcuni degli aspetti culturali, sarebbe utile perché non è solo una questione di lingua, ma anche una questione di cultura. Un conto è l’inglese della Scozia, dell’Irlanda o del Galles e un conto è l’inglese dell’India o della Giamaica. Perché in quel caso ci sono cose che sicuramente emageranno e che hanno radici in una cultura e anche in una lingua diversa dall’inglese classico.
Certe volte ogni tentativo di dare un’equivalente italiano è votato al fallimento. Ad esempio le metafore dei caraibici o degli indiani sono bizzarre, intraducibili per non dire “impossibili da far transitare” senza il supporto di una spiegazione. La priorità per me è ottenere il suono, il ritmo, poi se si riesce a mettere una nota, meglio.»
5. Prima accennavi all’invecchiamento della traduzione: pensi che poesia e narrativa invecchino in modo diverso?
«Penso che invecchino allo stesso modo. Penso anche che un certo tipo di linguaggio poetico, potremmo dire il poetichese, che è quella lingua pomposa, lirica in senso deteriore, che avevamo anni fa, adesso non è più proponibile.
Nel fare uno studio sulle traduzioni della Dickinson ad esempio, ho trovato questo linguaggio che ha molto a che fare con l’ermetismo o con certi stilemi pascoliani, se non addirittura leopardiani, che si ritrova tal quale nelle traduzioni degli anni ’50, nel dopoguerra, negli anni ’60, attribuiti oltretutto a un’autrice dell’Ottocento.
Quindi suona troppo italiana perché noi abbiamo un concetto di poesia tardo ottocentesco, primo novecentesco che ci condiziona tantissimo e da cui dovremmo sgombrare il campo per ritrovare un modo contemporaneo di tornare all’ottocento, a quel linguaggio innovativo, creativo, estremamente originale della Dickinson che già differiva nettamente rispetto ai suoi contemporanei.
Questo è solo un esempio, però si può applicare ad altri autori di cui non mi sono occupato. Quindi ho trovato molte traduzioni, pur ben fatte, pur coerenti, molto studiate, molto ben lavorate, però non convincenti, non restituivano questa originalità perché c’erano troppe sovrastrutture.
Magari erano poeti stessi che si cimentavano e quindi sovrapponevano il proprio linguaggio poetico, di Montale, di Luzzi, di Ungaretti, per carità eccellenti sotto altri punti di vista però in cui si sentiva molto la loro voce, diventava alla fine un esercizio di poesia propria, un aiuto alla loro scrittura, più che un tributo all’autore originale.
Per la prosa penso che sia più o meno la stessa cosa perché anche lì possiamo nominare dei grandi autori come Pavese e Vittorini che certamente hanno avuto il merito storico straordinario di far conoscere una certa letteratura americana dell’ottocento o dei primi del novecento ma che hanno tradotto imponendo fortemente la loro voce.
Anche nel dopoguerra, quando sono stati riscoperti quegli autori americani che per note ragioni erano stati banditi in Italia nel periodo tra le due guerre, la personalità del traduttore era molto forte anche se non si chiamavano più Pavese o Vittorini.
Mi viene in mente Adriana Motti che traduce The catcher in the rye di Salinger e imposta un proprio stile, molto barocco se vogliamo, molto manierista. Ricordo certe espressioni dei primi capitoli in cui c’è questo ragazzo che parla e la traduzione adotta delle soluzioni pirotecniche, mentre l’originale inglese è molto più lineare. Quindi nell’originale abbiamo un Holden Caulfield, il protagonista che è stato così influente per la letteratura italiana successiva, che suona molto più asciutto nel parlare ma anche più antipatico, più scorbutico, mentre quello italiano, appunto, ha tutte queste espressioni meravigliose, però create di sana pianta dalla traduttrice.

Quando è stato ritradotto in anni recenti, tra l’altro dalla mia mentore Anna Nadotti insieme a Matteo Colombo, è stato riportato ad una sua fedeltà, ma la maggior parte dei lettori è rimasta delusa perché non riconosceva più queste caratteristiche, anche tenere, di fragilità del protagonista che tanto avevano incuriosito ma che erano in gran parte merito, o in qualche modo demerito, della traduttrice del tempo.»
6. Ti ringrazio moltissimo Andrea, andiamo in chiusura: Quali sono gli autori che vorresti avere l’opportunità di tradurre?
«Come ho detto prima mi piacerebbe misurarmi con un classico. E se dovessi sceglierne uno direi forse un Robert Louis Stevenson.
Se qualcuno mi commissionasse un Dr. Jekyll & Mr. Hyde avrei delle idee su come tradurlo oggi. Se parliamo di narrativa, ovviamente.
Sulla poesia, beh, io ho cominciato traducendo due cose, i testi del prog britannico di Genesis, King Crimson e Pink Floyd e le poesie di T.S. Eliot. E con questo denuncio un po’ la mia età.
Ecco, in poesia mi piacerebbe riaffrontare qualcuno dei modernisti, quindi non solo Eliot, ma magari anche Ezra Pound, Yeats. Ma per quanto riguarda la Wasteland ci ha pensato di recente Carmen Gallo in maniera ottima per Il saggiatore, tra l’altro cambiando anche il classico titolo “La terra desolata” che è diventato con buone ragioni “Terra devastata”.»
In realtà vorrei essere un traduttore scout.
Ci sono tante autori non tradotti, mi piacerebbe far scoprire degli autori contemporanei o anche del passato che sono stati assolutamente ignorati. In poesia ce ne sono tanti, in narrativa forse meno ma tanta poesia non è abbastanza conosciuta, non è mai stata tradotta e varrebbe davvero la gioia.»
7. L’ultima domanda è: se qualcuno volesse intraprendere la carriera di traduttore oggi, che consigli vorresti dare?
«È veramente difficile, non so davvero quali consigli dare. Bisogna avere tanta passione, soprattutto per la lettura, cosa che magari molti ragazzi a scuola o all’università non hanno.
Conoscono molto bene l’inglese, magari perché fanno l’Erasmus o hanno la possibilità di prendere master, cosa che un tempo non era così semplice, però il gusto della lettura si sta perdendo, la curiosità per quello che si legge.
Quindi probabilmente il ragazzo più curioso, che vuole approfondire, vuole documentarsi, che da lettore si impone delle domande su un certo testo, è anche la persona avvantaggiata, più portata per affrontare in modo serio un’opera di traduzione, di riscrittura.»